Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasce a Stoccarda nel 1770. Non si può dire che la sua fosse stata una vita avventurosa, Dopo aver frequentato le scuole locali, si iscrive nel 1788 all’Università di Tubinga dove incontra il Hölderlin e Schelling, con i quali stringe amicizia. Allo scoppio della Rivoluzione francese simpatizza con i rivoluzionari, simpatia che resterà immutata per tutta la vita, al punto che ogni 14 luglio pare brindasse in memoria della presa della Bastiglia.
Conclusi gli studi si mantiene come precettore dei figli di un nobile bernese, fino al 1801 quando si trasferisce a Jena. In questi anni si compie il distacco sia dalla filosofia kantiana, che era il modello filosofico in voga ai tempi, con cui tutti gli intellettuali dell’epoca dovevano misurarsi, sia dall’amico Schelling, le cui idee gli sembreranno sempre meno valide, al punto che le criticherà fortementenel suo testo più celebre, La fenomenologia dello spirito, nel 1807.
Diventato nel 1808 rettore e professore a Norimberga si trasferisce nel 1816 ad Heidelberg, dove pubblica la prima edizione dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Qui rimane fino al 1818 quando diventa professore di filosofia dell’Università a Berlino. Muore nel 1831, dopo aver editato i Lineamenti di filosofia del diritto (1820) e la seconda e la terzaedizione dell’Enciclopedia.
L’intento programmatico di Hegel è la comprensione razionale della totalità del reale. Il termine in tedesco, in realtà, è Wirklichkeit, traducibile con “effettualità”. Per Hegel infatti l’intento della filosofia non è semplicemente la comprensione della realtà contingente (che chiama Realität), ma della sua logica intrinseca. Infatti la realtà, per essere wirklich, effettuale, deve essere necessariamente razionale: una realtà che non abbia una sua logica intrinseca non è possibile o al più è un’apparenza. Da qui l’affermazione hegeliana, contenuta nella prefazione dei Lineamenti di filosofia del diritto, «ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale»[1].
Osservare la realtà, infatti, non basta per comprenderla: non è semplicemente analizzando dei dati e generalizzandoli (il metodo induttivo degli empiristi) che si può dire di aver effettivamente compreso un evento o un processo: è necessario comprenderne infatti la struttura logica, e dunque dargli una forma, una sistematizzazione, che non può che essere razionale.
La via verso la conoscenza, dunque, per Hegel, consiste in un continuo confronto con il sapere apparente: più studiamo la realtà, più ne vediamo la struttura, e più siamo costretti a rivedere le nostre idee precedenti su di essa. Questo però significa che non esiste una teoria vera in assoluto, ma neanche un progressivo percorso di avvicinamento alla verità. In realtà il percorso può prevedere avanzamenti e arretramenti, momenti di presa di coscienza e momenti in cui la coscienza «perde la sua verità».
Come scrive nella Fenomenologia dello spirito, questo itinerario «Può quindi venir considerato come la via del dubbio o, più propriamente, la via della disperazione[2]». Non molto rassicurante, diciamo.

Questo processo, però, non è il «vuoto nulla» dello scettico. Nel pretendere di «scalzare questa o quella verità[3]», affermando l’inconsistenza di ogni sapere, lo scettico finisce per affermare almeno una verità, e cioè l’inesistenza di ogni verità. Lo scetticismo, dunque, non è una via praticabile perché contraddittoria.
Negare un concetto, inoltre, significa affermarlo. Per dire che una cosa (che chiameremo “A”) non esiste, io devo avere il concetto di “A”, e quindi devo averla affermata, almeno in quanto concetto. Se per me “A” non esistesse in alcun modo, non potrei nemmeno pensarla, e dunque nemmeno negarla. Vale anche l’inverso.
Citando Baruch Spinoza, Hegel afferma che «omnis determinatio est negatio», ogni determinazione è una negazione: affermare che “A” è “A”, significa infatti dire che “A” non è “B”, non è “C”, non è “D”, e così via. Se ci pensiamo, anche nella nostra vita quotidiana ci troviamo spessissimo a definire noi stessi e ciò che ci circonda per negazione, più che per affermazione: ciò che non siamo ci definisce quanto ciò che noi siamo.
Però, se ogni affermazione è una negazione e viceversa, come si può pensare che esista una verità? Se affermo “A”, e per me questa è una verità, e questa verità poi diventa “non A” (o, per usare il segno convenzionale in filosofia, “¬A”), potrei affermare tutto e il contrario di tutto: come fare?
In realtà, come abbiamo già visto, c’è una differenza tra il negare “A” in senso assoluto e il negare “A” perché “A non è B”. Io, per esempio, posso dire «La casa di fronte a me è rossa», perché so che il rosso non è verde, non è blu, non è marrone, e così via, o che una casa non è un albero o una macchina.
Vale a dire che l’identità di una cosa si determina in relazone alla differenza di quella cosa rispetto a tutto il resto. Se non ci fosse questa possibilità, noi non potremmo dire nulla della realtà. Avremmo solo un insieme indistinto, un blob in cui non possiamo distinguere alcunché.
In altre parole, se ogni affermazione è negazione, la verità non consiste nell’affermare “A” o nel negarla, ma nel riconoscere l’intrinseca relazione che lega l’affermazione alla negazione, cioè la tesi all’antitesi.
Questo significa che la verità non è qualcosa di statico, non significa affermare staticamente qualcosa o negare staticamente qualcosa, ma è un processo che riguarda la relazione tra tesi e antitesi, E significa anche che il sapere è il ripercorrere questa relazione, è lo svolgersi razionale di questo processo, la sua spiegazione.
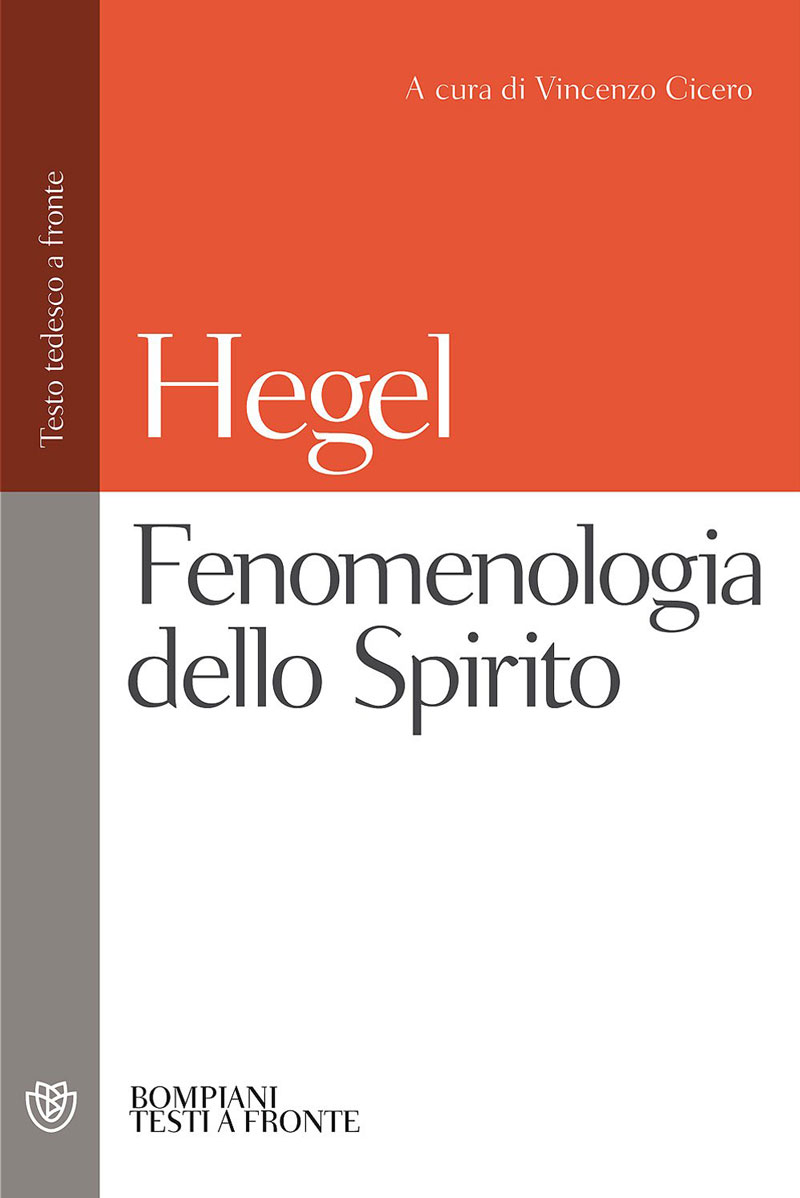
Però c’è ancora un fatto da chiarire. Se non aggiungessimo null’altro a queste affermazioni, si potrebbe dire che la verità è un processo che dall’affermazione va alla negazione e viceversa. Sarebbe come una partita a ping-pong tra questi tesi e antitesi, senza che questo costituisca un avanzamento di qualsiasi tipo. Dalla tesi all’antitesi, dall’antitesi alla tesi.
Tutto ciò produrrebbe una conoscenza tautologica. Io so che “A è A” perché “A non è B”, io so che “B non è A” perché “A è A”. Hegel qui fa un salto ulteriore: è necessario negare nuovamente l’antitesi perché si raggiunga a un terzo stadio della conoscenza, che non è né tesi né antitesi. Non è l’antitesi perché ne è la negazione, ma non è neanche la semplice riaffermazione della tesi: è il riconoscimento della superiore unità che lega «A» a «¬A», superare la contrapposizione, ma mantenendo ciò che di positivo è scaturito dalla contrapposizione. In tedesco esiste una parola per questo movimento ed è Aufhebung: superamento con conservazione.
Facciamo un altro esempio, questa volta tratto da Hegel[4].
L’essere, ciò di cui si può solo dire che è, deve necessariamente contrapporsi a ciò di cui possiamo dire solo che non-è: al non-essere. Abbiamo qui due proposizioni necessariamente contrapposte ed egualmente vere (e false): «l’essere è» e «il non-essere non è, Con queste due proposizioni cominciò, con Parmenide, tutta la filosofia occidentale: per Parmenide questa era addirittura la prova dell’apparenza della realtà: la realtà che vediamo non può essere vera, perché è contraddittoria, Se l’essere e il non essere si mescolano, si intrecciano, questo è irrazionale, e dunque non può essere vero.
Hegel risolve il problema con questo processo che dalla tesi passa all’antitesi e arriva al superamento, all’aufhebung: la dialettica. E la dialettica non è altro che la spiegazione razionale del divenire. Se un uomo è un uomo e non è un bambino, questo è vero in una prospettiva sincronica: in una prospettiva diacronica, invece, un uomo è stato un bambino, e oggi non lo è più. Il divenire, dunque, non è semplicemente lo scorrere del tempo, ma è lo sciogliersi delle contraddizioni: man mano che la storia umana procede, vi sono contraddizioni che si risolvono e nascono nuove contraddizioni, che a loro volta si risolveranno.
Questo è importante per un motivo: la contraddizione non è un problema per la realtà, non è quell’elemento da eliminare perché sbagliato, irrazionale. Al contrario, è il motore della realtà. L’opposizione dei momenti dialettici si scoglie attraverso il divenire, trova ogni volta una sua risoluzione, che però non è definitiva, e genera nuove opposizioni, nuove contraddizioni, che a loro volta verranno sciolte con il passare del tempo.
Lo si vede bene se pensiamo alla storia: le lotte di potere, gli avanzamenti tecnologici, le nuove scoperte possono essere tutte lette come risoluzioni di precedenti contraddizioni, che però poi hanno portato a nuove problematiche, che hanno necessitato di nuove soluzioni e così via. Lo si vede anche pensando alla storia della cultura (che Hegel chiama spirito),
Nel Seicento era diffusa, per esempio, l’idea che la realtà fosse una costruzione del soggetto, dell’uomo che la stava osservando. Famosa è l’affermazione di George Berkeley, «Esse est percipi»: l’essere è percezione. «La realtà è idea», potremmo dire: è l’uomo che ha costruito la realtà. Contrapponendosi a questa visione, l’empirismo invece affermò che «La realtà è materia». Hegel, a sua volta, nega la negazione, e afferma, molto cristianamente tra l’altro, che «La realtà è idea che si fa materia».
Siamo tornati al punto di partenza: la realtà è sì idea, ma che si fa materia. Il punto di vista diventa così sempre più completo e onnilaterale. Una comprensione che è autocomprensione del processo dello spirito, cioè della storia della cultura umana. Dall’enunciazione di un principio si è arrivati a una sistematizzazione del sapere umano, che non appare più come il susseguirsi di dottrine più o meno arbitrarie, ma come un processo unico e coerente, in cui le opposizioni trovano man mano una spiegazione e una risoluzione in forme di comprensione sempre più ampie: il cammino verso la comprensione della totalità.

